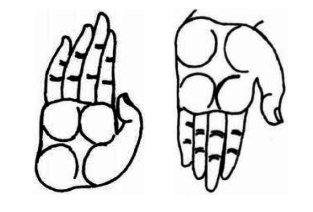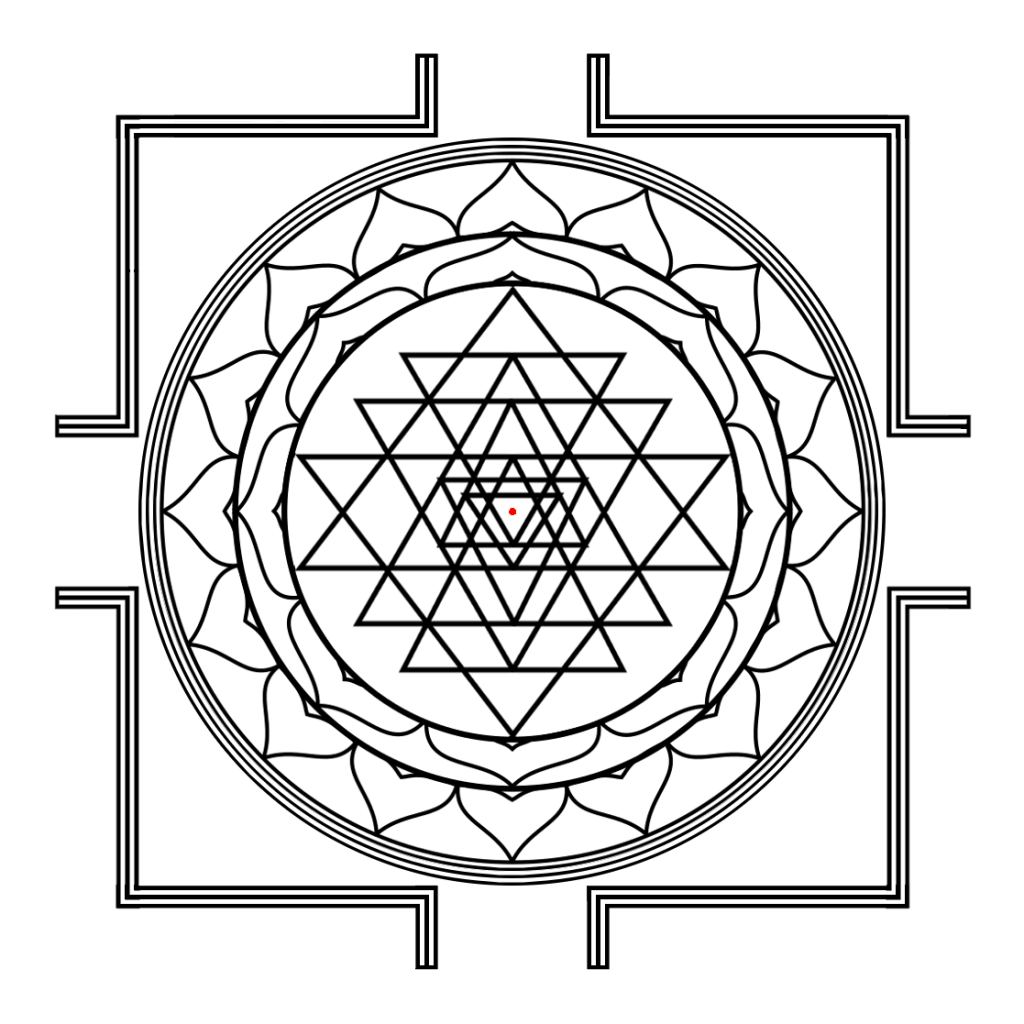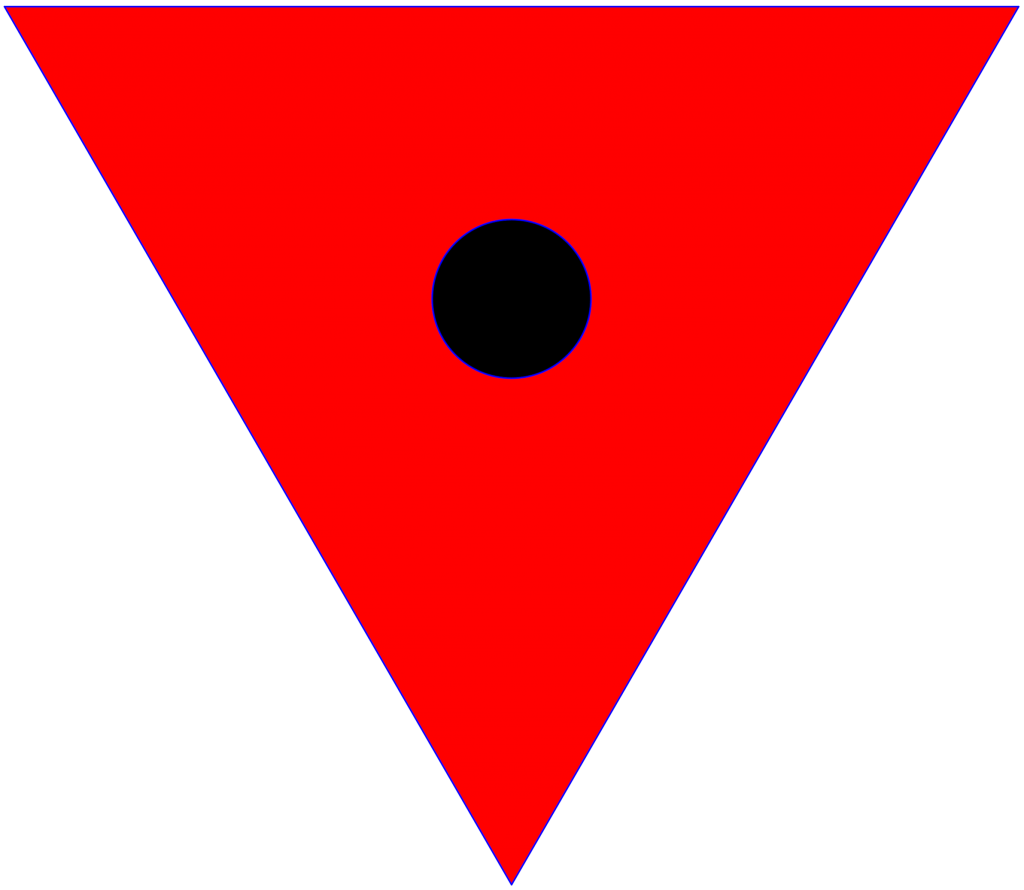1. La Luce della Realtà
Śrī Śrī Svāmī Prakāśānandendra Sarasvatī Mahārāja
La Luce della Realtà
Il metodo delle tre avasthā
Traduzione, prefazione e note a cura di
Maitreyī e Devadatta Kīrtideva Aśvamitra
Prefazione
Con tutto il mio essere mi prosterno ai sacri piedi,
che dissipano la paura per le continue nascite e morti,
del mio grande guru che, con la luce della sua conoscenza,
ha dissolto le tenebre dell’illusione che coprivano la mia mente.
(Māṇḍūkya Upaniṣad Śaṃkara Bhāṣya, IV.100)
Nel 1941 Śrī Śrī Svāmī Satcidānandendra Sarasvatī Mahārāja raccolse una serie di suoi insegnamenti rivolti ai discepoli di jñāna yoga, che pubblicò in lingua kannaḍa con il titolo di Paramārtha Cintāmaṇi (La gemma metafisica che realizza tutti i desideri)1. Il tono dell’insegnamento orale diretto ad personam mutò nello stile della trattatistica vedāntica (siddhānta), con citazioni delle fonti e con riferimenti rigorosi2. Si tratta di una delle opere di maggior rilevanza del grande maestro advaitin, radicata principalmente sui commenti di Śaṃkarācārya alla Māṇḍūkya Upaniṣad e alle Kārikā di Gauḍapāda. L’argomento del testo riguarda il metodo dei tre stati (avasthātraya mīmāṃsā), l’unico strumento conoscitivo capace di dissolvere l’ignoranza al fine di riconoscere la propria eterna natura di Assoluto, di Brahmātman. Con argomentazioni inconfutabili fondate sulla sua esperienza intuitiva, con l’ausilio subordinato di una logica serrata e in pieno accordo con le tre fonti (prasthāna traya) della metafisica vedāntica, Upaniṣad, Brahma Sūtra e Bhagavad Gītā, Pūjya Satcidānandendra Mahārājajī ha composto un incomparabile manuale per i cercatori della conoscenza suprema (jijñāsu).
Undici anni dopo che Svāmījī aveva lasciato il corpo, Devidas Bhavanishanker Gangolli3 intraprese la traduzione del Paramārtha Cintāmaṇi in inglese, al fine di rendere accessibile un’opera così fondamentale anche ai non conoscitori della lingua kannaḍa. Nel 1986 apparve dunque il libro The Magic Jewel of Intuition4. Prudentemente, Gangolli pubblicò il libro a suo nome, come se ne fosse stato l’autore. Egli aggiunse al titolo, non molto felice in quanto evoca la magia che è del tutto fuori luogo in contesto vedāntico, il seguente lungo sottotitolo: “This is a free transaltion of Kannada book “Paramartha Chinthamani” written by Sri Sri Sachidanandendra Saraswathi Swamiji, of Adhyatma Prakasha Karyalaya”5. Lo sforzo compiuto da Gangolli con questa traduzione è stato notevole e gliene deve essere riconosciuto il merito. Tuttavia la sua incompleta preparazione dottrinale e il suo inglese zoppicante ne rendono difficoltosa la lettura, ragion per cui, in taluni punti, alcuni concetti rimangono oscuri.
Al fine di por riparo a questa manchevolezza, Śrī Śrī Svāmī Prakāśānandendra Sarasvatī Mahārāja6 s’è impegnato alla ritraduzione inglese dell’importante trattato del suo predecessore. All’inizio della sua opera di traduzione, Śrī Prakāśānandendra Svāmījī si apprestò ad aggiungere alcune spiegazioni ulteriori, a sopprimere certe ripetizioni, e, soprattutto, a semplificare il linguaggio del testo originale. Prese così l’iniziativa di abbandonare lo stile trattatistico, caratteristico del siddhānta classico, riproponendo il contenuto nella forma dell’upadeśa7; in questo modo, in luogo di una trattazione unicamente dottrinale, il testo è ritornato a essere un insegnamento principalmente metodico, la trasposizione della śruti nella parola quale mezzo di conoscenza (śābda pramāṇa) al fine di indurre i discepoli all’esperienza di śravaṇa8. Avendo così deciso, Svāmī Prakāśānandendra Sarasvatī Mahārāja, pur avendone mantenuta intatta l’architettura di base, ha riscritto da capo a fondo il testo primitivo, producendo così un’opera del tutto originale. Le concezioni più complesse e le difficili dimostrazioni logiche si sono così sciolte in un linguaggio piano, accessibile, di una chiarezza talvolta sconcertante. A tal fine l’Autore ha persino evitato l’uso del linguaggio tecnico in sanscrito, se non nei casi in cui fosse stato strettamente indispensabile. È stata una scelta dei curatori mantenere le ripetizioni e la divisione in brevi paragrafi, importanti per il fine didattico (upadeśaka artha) caratteristico di questo manuale.
Siamo consapevoli che, in ogni caso, l’elevatezza della materia non potrà essere colta da tutti: la conoscenza, infatti, è comprensibile soltanto alle persone qualificate e mature. Ma anche lo sforzo intellettuale di coloro che, durante la lettura, si trovassero in difficoltà, non resterà senza frutto e potrà essere usato per la purificazione della mente9.
La Luce della Realtà è sempre rimasto un manoscritto. La vita errabonda di Gurujī è stata d’ostacolo alla sua pubblicazione. È motivo di onore e di privilegio che appaia per la prima volta a stampa in questa edizione in italiano.10
Maitreyī e Devadatta Kīrtideva Aśvamitra
Introduzione dell’Autore
Oṃ Śrī Gurubhyo Namaḥ
Cos’è l’akarma? “Io sono akartā”, aveva detto Kṛṣṇa (BhG IV.17-18). Finché la mente è in relazione con il mondo esterno si è un individuo. Invece il jñāni è come uno specchio che riflette le cose. Quando il volto che si riflette se ne va, lo specchio non ne trattiene la forma. È come il Testimone (Sākṣin) che, libero dal karma, anche quando compie azione è solo uno specchio, essendo l’azione solo un’apparenza su di lui. Quindi le cose appaiono solo dal punto di vista del mondo. Sembra avere un corpo e agire come tutti. In sé, invece, è come uno specchio e non ha alcuna relazione con il karma. Il karma è l’individualità; in altre parole, è la persona nello stato di veglia o di sogno. Akarma non significa rimanere ozioso senza compiere azione, come volgarmente si crede. Quello è ancora karma11. Se si vede l’illuminato agire, in realtà, lì non c’è karma né karma phala. Il jīva stesso è il karma, è lo stato che comprende tutte le relazioni. Chi capisce che il karma per lui non esiste, nonostante lo stato, l’individualità, l’agire e le relazioni con il mondo, costui trascende l’intero stato, si risveglia dallo stato che per lui non esiste più: questo è akarma. Per l’illuminato, akarma significa lasciare l’individualità, tutto lo stato, scoprendosi Testimone dello stato. Capendo così, la persona che intuisce la sua natura di Testimone (Sākṣibhāva) è il vero akartā. In questo modo è libero dalla volontà: capisce che essa è della mente, mentre il Sākṣin sa di non essere la mente. Il jñāni lascia la mente ed è naturale e spontanea esistenza. Quindi vede scorrere le cose come quando si è sulla riva di un fiume e si guarda l’acqua fluire. È neutrale e spontaneo, non ha nessun coinvolgimento nel movimento: il movimento solo gli appare. È conscio di esso, ma non ne è parte. Così le cose del mondo si muovono e avvengono attorno a lui. Questa non identificazione del Sākṣin è già in noi, non si deve fare nulla per diventarlo. Bisogna solo fare attenzione (nididhyāsana), guardare se stessi, essere in uno stato in cui non si agisce né in positivo né in negativo, che sono soltanto stati della mente. Questa è l’esistenza naturale. Quindi non c’è alcuno sforzo per essere Sākṣin. Non ‘si diventa’ il Sākṣin né facendo né non facendo, perché la Coscienza non ha il senso dell’ego (ahaṃkāra) che è solo un pensiero della mente. Il Sākṣin non ha il senso dell’ego; è come nel sonno profondo, in cui si esiste senza il pensiero dell’ego. Cioè solo “Io” (Ātman) esisto12. La volontà non serve per trascenderlo. Che cos’è allora l’akarma, se fare azione o il non fare azione è caratteristica della volontà? È una scoperta di conoscenza, non un karma. Per tale ragione Śaṃkara afferma che non con il karma, ma soltanto con il jñāna si raggiunge mokṣa. Usare la volontà è un legame, mentre la libertà è uno stato naturale. Rivolgendosi verso l’interno di Sé c’è un nocciolo che è libero dalla volontà, perché la volontà è un cambiamento nella mente e il cambiamento appartiene alla mente, non al Sākṣin. Il Sākṣin è spontaneo ed è la coscienza dell’intero lo stato di veglia preso come un tutt’uno. La parola coscienza ha due aspetti. Una è la coscienza del mondo e dei suoi oggetti; quando si è consci delle cose una a una, quello è uno stato della mente. Ma la coscienza di tutti gli oggetti, compresa la mente, presi come un tutt’uno, quella è la coscienza dell’intero stato. La coscienza dello stato non subisce modificazioni, è lì naturalmente: invece, la mente subisce cambiamenti. Quando si guarda il libro, si ha il pensiero del libro; quando si vede l’albero, si ha il pensiero dell’albero. Il pensiero è mutevole, mentre la coscienza della veglia non cambia. Perciò la buona azione e quella cattiva, fare e non fare, sono tutti all’interno della veglia; sono all’interno dello stato quando gli organi di senso e la mente sono in funzione. Tutti questi, indriya, mente, intelletto, senso dell’‘io’, sono nella coscienza di veglia. La coscienza di veglia non viene né va né rimane inerte. È lì spontaneamente di per se stessa. Noi in generale sovrapponiamo la mente alla coscienza e consideriamo la coscienza come fosse solo la mente. Questa è la mutua sovrapposizione (anyonya adhyāsa). Osservando, si è in grado si vedere. Questa osservazione è l’indagine sul Sé. Lo śāstra indica di osservare attentamente. Per scoprirlo si deve solo prestare attenzione. Soggetto-oggetto, spazio-tempo, conoscitore-conosciuto, sono tutti nella coscienza. Quindi l’intero mondo di veglia, l’intera mente, l’intero stato di veglia appaiono, scompaiono e si dissolvono nella coscienza. E, ancora, la coscienza rimane nel sogno. Poi l’intero mondo del sogno si dissolve e rimani te stesso nel sonno profondo. Il sonno profondo è solo la coscienza di veglia quando il mondo e l’‘io’ è dissolto. Quindi le idee dell’uomo comune sul sonno profondo sono: che è un passato, che è nulla, che è solo oscurità. Questi sono solo errori, sovrapposizioni create dalla mente dal punto di vista della veglia. Il sonno profondo non è un passato, perché è senza tempo. Libero dal tempo significa che è sempre esistente: se è sempre esistente, non può essere passato13. Non è nemmeno un vuoto, perché per definirlo così si richiede una mente che lo immagini in questo modo. La mente del vegliante lo definisce vuoto od oscuro, perché paragona il sonno profondo alla veglia. Quindi lo dichiara diverso dalla veglia. Questa mente non è capace di afferrarlo, perché il sonno profondo è libero dalla mente. La mente non può immaginare la non-mente, il pensiero non può immaginare il non-pensiero, perciò lo definisce vuoto, nero, passato, nulla. Ma la reale esperienza di suṣupti è la scomparsa della mente. Quando la mente della veglia è dissolta nella Coscienza, tutta la coscienza di veglia è inghiottita ed è solo Coscienza, sei tu stesso. Il pramātā della veglia pensa di andare in sonno profondo e da lì ritornare. Questo è un errore, perché né si va né si viene. La persona della veglia rimane nella veglia. Se non c’è stato di veglia, che senso ha dire andare? Infatti la persona della veglia è parte dello stato di veglia. Quando s’inghiotte lo stato di veglia che senso ha chiedersi dov’è il pramātā della veglia? Anch’egli è dissolto assieme alla veglia. È la persona della veglia che pensa di andare in sonno, di dormire per un certo tempo e poi di tornare indietro. Ma come può la persona della veglia lasciare la veglia per andare da una qualche altra parte? Può uscire dalla veglia? È come dire che la persona che sta sperimentando il sogno, lasci il sogno e ne esca. Non è possibile, perché quando il sogno non c’è, anch’essa scompare. La persona del sogno non può esistere al di fuori del suo stato di sogno. Rimane solo come Sākṣin del sogno. Come lo schermo quando finisce la proiezione. È la coscienza di sogno, che è il testimone del sogno, a essere sempre cosciente dell’intero sogno. Ma quando mai la persona del sogno si risveglia? La persona del sogno rimane lì, nel sogno. La coscienza dell’intero stato di sogno rimane incontaminata dall’individuo del sogno. Inghiotte l’individuo del sogno assieme al mondo del sogno e allo stato del sogno. Stato, mondo e individuo, tutti tre sono inghiottiti e rimane solo la coscienza del sogno. Essa rimane come è. «Io mi sveglio». Ma chi si sveglia? La persona del sogno va via, scompare con il sogno. Svegliarsi vuol dire che tutta la coscienza del sogno rimane non toccata dalla persona del sogno e che tutto è inghiottito, il mondo, la persona e lo stato del sogno: rimane solo la coscienza del sogno, che ‘è’, che esiste. È Quello, che si sveglia. L’individuo che pensa di essersi svegliato, non è mai stato dentro al sogno. L’intera coscienza della veglia pervade l’intero stato. Questa intera coscienza non è una parte, non è collocata in un certo luogo della veglia. La coscienza della veglia esiste nello stato della veglia? Questa è una buona domanda. Questa intera coscienza è localizzata in un certo punto? Se noi dicessimo così, sarebbe legata, limitata da tempo, spazio, corpo ecc. La coscienza di veglia non è legata in questo modo. È il soggetto (pramātā) della veglia che è parte della veglia, che è in relazione con un oggetto alla volta e che vede gli oggetti al suo stesso livello. Così fa anche la persona del sogno quando vede gli oggetti del sogno. Ma quando ci si sveglia e si ricorda il sogno, la coscienza di veglia che “ricorda” non pensa che il sogno sia al suo stesso livello, poiché allora la coscienza (che in realtà non “ricorda”), essendone uscita, è consapevole che l’intero stato di sogno era irreale. Quando c’è la relazione tra bhoktā-bhogya (fruitore-fruito), kartā-kārya (agente-agito), jñātā-jñeya (conoscitore-conosciuto), allora si è allo stesso livello. Ma, mentre si è in veglia si pensa di essere a un livello completamente diverso da quello del sogno. Finché la persona della veglia pensa di andare a dormire, è sempre in veglia, ma quando dorme davvero, non c’è più veglia. Nel sonno profondo non c’è affatto veglia, perché tutto lo stato di veglia è stato inghiottito assieme alla persona della veglia. Perciò lì non c’è più la divisione tra mondo della veglia e persona della veglia, non c’è più la linea divisoria tra oggetto e soggetto. Tutto il mondo sei Tu. Tutto il mondo può essere ridotto a un pensiero. Quando si è svegli si sperimenta tutto come ‘questo’ (idam); tutto il mondo è sperimentato come ‘questo’. È un pensiero generale dell’intero mondo. In esso c’è l’ego e il resto degli oggetti mondani. Quindi tutto il mondo è ridotto a due. C’è solo un pensiero di ‘io’ e il resto. C’è dunque solo questa esperienza di dualità di soggetto-oggetto. Quando si toglie questa linea divisoria tra soggetto e oggetto, si dorme. Il sonno è un’esperienza di coscienza in cui non ci sono soggetto e oggetto. Nella veglia c’è il pensiero di io e di questo (idam), l’oggetto che vedo. L’‘io vedo questo’ è una relazione tra io e ‘questo’. Questa relazione è il vedere. Ma nel sonno profondo non c’è l’ego, non c’è il pensiero dell’io né di ‘questo’, perché entrambi si immergono in ‘uno’. C’è semplicemente Coscienza. Quindi, nel sonno profondo non c’è divisione, separazione, molteplicità, che invece è sovrapposizione senza inizio (anādi adhyāsa). Non si può dire quando l’adhyāsa inizi, perché l’inizio è nel tempo, cioè è un pensiero; e se non c’è pensiero non c’è nemmeno divisione. Si può solo dire che ci si ritrova come Coscienza. “Quindi, l’individuo che capisce che l’individualità è immaginata in lui, capisce di essere non agente (akartā).” (BhGŚBh IV-18) Questo è il vero akarma. Compiere azione e non compiere azione è sempre azione. Finché pensi di essere parte dello stato tu sei un kartā, cioè un individuo. “Il vero akarma è capire che tutto lo stato è immaginato in me. Dal mio punto di vista io non lo vedo, io non sono un individuo.” (ibid.) La coscienza e la mente non sono due cose. Quando la coscienza è in relazione con qualcosa, la chiami mente, cioè una coscienza relativa (es: io vedo qualcosa). Quando la relazione è rimossa, la Coscienza senza relazione è il Sākṣin. Quella con relazione è nello stato, è il jīva. Non si deve pensare che la mente sia una entità, una sostanza fisica; è solo la Coscienza considerata in relazione. È un pensiero. Il pensiero non è una cosa fissa, come il tavolo o il libro, è una coscienza relazionata. Ma il Sākṣin non vede ‘altro’ da Sé, perché il soggetto vede l’oggetto, ma se il soggetto non c’è, non c’è più l’oggetto. Nella vera Coscienza non c’è più né ‘io’ né oggetto, e allora lì si è liberi da karma.
Svāmī Prakāśānandendra Sarasvatī
Oṃ śānti śānti śāntiḥ
- Svāmījī nel 1966 ha riveduto e ampliato la seconda edizione del libro.[↩]
- I cristallini riferimenti alle fonti da cui si attinge è la garanzia della trasmissione ricevuta. Anche la trasparenza sulla propria paramparā è una precisa attestazione di legittimità d’insegnamento, indispensabile per garantire l’aspirante discepolo sulla veridicità e correttezza di quanto gli sarà trasmesso assieme e a seguito dell’iniziazione. Così si comportano e si comportarono gli autentici guru: lo stesso Śaṃkara non fece mai mistero in proposito: non si richiamò all’autorità di misteriosi maestri o di fantomatici superiori sconosciuti né mai affermò di non essere tenuto a svelare le sue fonti. Il velo di segretezza sulle fonti e sul contenuto d’insegnamento orali, scritturali e sulla loro trasmissione è, invece, caratteristica degli ambienti occultisti, teosofisti e New Age sorti in Occidente negli ultimi tre secoli, nonché dei “guru in Rolls Royce” e delle sette falsamente tradizionali.[↩]
- D. B. Gangolli, è stato un discepolo di Svāmī Anandāśrama Mahārāja del Citrapur Sarasvat Brāhmaṇa, dal quale fu iniziato al karmayoga. Nel 1970 incontrò Svāmī Satcidānandendra Mahārāja, di cui diventò discepolo. Tradusse in inglese una ventina delle opere di questo maestro.[↩]
- The Magic Jewel of Intuition. The Tri-Basic Method of Cognizing the Self, Holenarasipura, Adhyātma Prakāśa Karyālāya, 1986.[↩]
- “Questa è una libera traduzione del libro in kannaḍa “Paramartha Chinthamani” scritto da Sri Sri Sachidanandendra Saraswathi Swamiji, del Adhyatma Prakasha Karyalaya”.[↩]
- Pūjya Prakāśānandendra Sarasvatī Svāmījī è un paramahaṃsa saṃnyāsin, un rinunciante parivrājaka (errante), Gurujī è il successore di Svāmī Satcidānandendra Mahārājajī al Śaṃkara Vedānta Pītham e suo rappresentante presso la fondazione Adhyātma Prakāśa Kāryālaya.[↩]
- L’insegnamento orale diretto tra maestro e discepolo.[↩]
- L’‘ascolto’, tecnica di contemplazione in uso nel metodo del jñāna yoga.[↩]
- Siamo altresì consapevoli che altri, che si ritengono sapienti di letture libresche e perfino iniziati, sclerotizzati nelle diverse prospettive della conoscenza non suprema, rifiuteranno aprioristicamente di capire. Come dice Śaṃkara, costoro appartengono alla categoria di coloro che non riconoscerebbero la verità nemmeno se la si porgesse loro “come una mela cotogna sul palmo della mano” (Upadeśa Sāhasrī, XVIII.182). Caso esemplare: recentemente dei cattolici convertiti all’islam, con pretese pseudo sufiche, hanno voluto insegnarci un loro ‘vero Vedānta’ islamizzato, criticando, con l’arroganza tipica, Jagadguru, ācārya e sādhaka advaitin contemporanei, correggendo Gauḍapāda, Śaṃkara, Sūreśvara e persino deformando le Upaniṣad con interpretazioni sincretiste a base creazionistica e ritualistica. Senza il minimo senso del pudore, hanno sostenuto nelle loro riviste cartacee e nei loro blog, come “vera tradizione advaita” le dottrine deviate della mūlāvidyā e del satkāryavāda, perché confacenti al loro limitato punto di vista dualista, in netta contrapposizione all’Adhyāsa Bhāṣya e alla vivartavāda śaṃkariane. L’improntitudine degli ignoranti non conosce davvero né limite né senso del grottesco! Naturalmente chi non è ottuso saprà facilmente fare discriminazione tra ciò che è vero e ciò che non lo è (satasat viveka).[↩]
- Questo trattato è già stato pubblicato in formato cartaceo con il medesimo titolo, per i tipi di Ekatos Ed. Pr, Milano, 2020.[↩]
- Se il guardiano vede un ladro entrare in una casa per la finestra e non interviene, egli non è un akartā. Ha semplicemente deciso di rimanere ozioso. La sua decisione è comunque una azione mentale intesa a ottenere un risultato: quello di evitare il pericolo. [N.d.CC.] [↩]
- Chi non ha una visione metafisica commette l’errore di confondere l’ego individuale con l’Ātman. A causa di questa sovrapposizione dovuta alla sua ignoranza, può confondere la dottrina del Brahmātman per un banale solipsismo. Se in India c’è stata una teoria simile al solipsismo, essa fu il vijñānavāda buddhista, severamente criticato dall’Advaitavāda. [N.d.CC.] [↩]
- L’ignorante, quando si sveglia dal sonno profondo, è convinto che ‘prima’, ‘mentre dormiva’, si trovava in suṣupti, mentre ora è in veglia. Ma il sonno profondo è fuori di ogni relazione temporale; in sonno profondo non si sperimenta né ‘prima’ né ‘dopo’, perché lì non c’è tempo. [N.d.CC.] [↩]